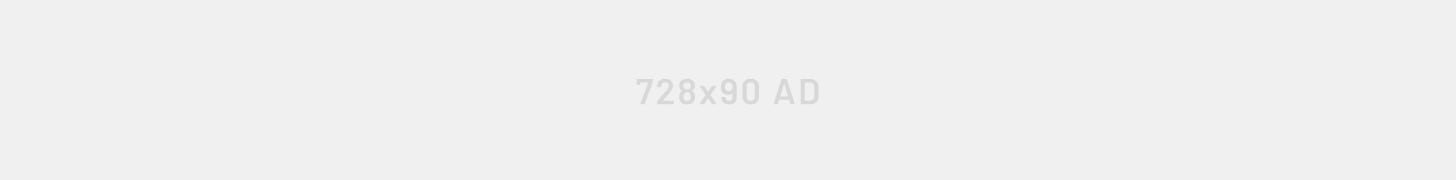Ricottini (pediatra allergologa): «Il cambiamento climatico ha modificato la stagionalità e l’intensità delle allergie. L’aumento delle temperature e delle concentrazioni di CO₂ ha prolungato i periodi di fioritura e aumentato la quantità di polline nell’aria»
di Elisabetta Turra
Pollini rilasciati da piante come graminacee, betulla, cipresso, parietaria e olivo sono le cause più comuni delle allergie primaverili. «Questi allergeni possono scatenare rinite allergica, con sintomi quali starnuti, naso che cola, prurito agli occhi e congestione nasale – spiega la dottoressa Lucilla Ricottini, pediatra allergologa, in un’intervista a Voce della Sanità -. Alcuni soggetti possono sviluppare anche asma allergico, con tosse e difficoltà respiratorie. È importante ricordare pure che il polline di betulla, in particolare, può crociare con alcuni alimenti che gli somigliano nella struttura proteica. Si tratta di frutta (pesca, mela, albicocca, prugna, kiwi), verdure (carota, sedano, finocchio, peperone) e frutta secca (noci, nocciole e mandorle). I sintomi delle allergie crociate sono soprattutto di tipo gastrointestinali e solo in casi eccezionali si possono presentare reazioni anafilattiche (sono reazioni allergiche improvvise, potenzialmente gravi e letali, ndr)», aggiunge la dottoressa Ricottini.
Cambiamento climatico e stagionalità delle allergie
I sintomi tipici delle allergie primaverili, oggi, possono essere percepiti anche fuori stagione: «Il cambiamento climatico ha modificato la stagionalità e l’intensità delle allergie. L’aumento delle temperature e delle concentrazioni di CO₂ ha prolungato i periodi di fioritura e aumentato la quantità di polline nell’aria – commenta la specialista -. Inoltre, la maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi, come ondate di calore e inquinamento atmosferico, soprattutto il particolato fine (PM2.5) possono peggiorare le reazioni allergiche L’inquinamento atmosferico, in particolare, potenzia l’effetto irritante dei pollini sulle vie respiratorie e aumenta la produzione di IgE, aggravando le reazioni allergiche nei soggetti predisposti”. A favorire le reazioni allergiche possono essere anche i ritmi frenetici della vita di tutti i giorni: “Uno stato di infiammazione cronica, accentuata da stress ambientali e fattori dietetici, può rendere il sistema immunitario più predisposto a rispondere in modo esagerato a stimoli allergenici», aggiunge la dottoressa Ricottini.
La diagnosi
La diagnosi si basa su anamnesi clinica, test cutanei (prick test) e analisi sierologiche (ricerca IgE specifiche, gli anticorpi della reazione allergica). Vediamoli nel dettaglio:
- Prick Test: applicazione di estratti allergenici sulla pelle per valutare una reazione immediata (IgE-mediata). È rapido ed economico, ma può essere influenzato dall’uso di antistaminici o da condizioni dermatologiche.
- ISAC Test: un esame del sangue avanzato che analizza simultaneamente la presenza di IgE specifiche contro oltre 100 allergeni a livello molecolare. È utile anche per distinguere allergeni primari da reazioni crociate (es. allergie alimentari associate ai pollini). La diagnosi di allergia viene posta quando i sintomi clinici si accompagnano alla positività dei test cutanei o sierologici.
Età di insorgenza delle allergie
Le allergie possono insorgere sia in età infantile sia in età adulta. «Sebbene molti soggetti sviluppino sensibilizzazione già da piccoli, alcuni fattori ambientali e immunitari possono portare alla comparsa di allergie anche in età avanzata. Questo fenomeno è spesso legato a tre principali fattori. Il primo è un’infiammazione di tipo 2, che compromette la barriera delle mucose e aumenta la permeabilità agli allergeni. Poi, una disbiosi intestinale, che altera la regolazione della risposta immunitaria a livello della barriera mucosa. Infine, un’esposizione prolungata a inquinanti o irritanti ambientali, che cronicizzano l’infiammazione e abbassano la soglia di reattività allergica», dice la pediatra allergologa.
I trattamenti: dai farmaci alle soluzioni naturali
Tra i farmaci consigliati per il trattamento delle allergie ci sono «antistaminici, corticosteroidi nasali, broncodilatatori per l’asma e immunoterapia specifica (conosciuto come vaccino per le allergie)», dice la dottoressa Ricottini. Tra i rimedi naturali «lavaggi nasali con soluzione salina, integratori a base di quercetina (azione antinfiammatoria), vitamina C, probiotici per modulare la risposta immunitaria e fitoterapia (come il ribes nero, che ha effetto cortison-like). È importante ricordare anche la vitamina D3 che, in giusta concentrazione nel sangue, sembrerebbe ridurre i sintomi allergici e soprattutto prevenire la comparsa di sintomi nei soggetti predisposti per familiarità». Infine, anche azioni preventive possono offrire un contributo importante. «Consiglio di evitare l’esposizione ai pollini nei giorni di alta concentrazione, utilizzare filtri antipolline e purificatori d’aria, e tenere chiuse le finestre nelle ore critiche», conclude la specialista.